SACROBOSCO: "Multidimensionality fascinates me"
- Andrea Ghidorzi

- 1 lug 2025
- Tempo di lettura: 8 min
Aggiornamento: 2 lug 2025
With SACROBOSCO, we’re not facing a mere artist, but a medium navigating between experiential dimensions: analog and digital, human and algorithmic, memory and glitch.

His compositions surface from psychic depths, like sonic debris caught in the teeth of a broken time machine. But this isn’t nostalgia—it’s emotional resistance. A radical affirmation of identity in a world dissolving into algorithmic liquidity.
With “Once”, SACROBOSCO molds time like clay, sculpting landscapes of memory through a language both sacred and technical, biological and artificial. His music isn’t consumed—it’s traversed. Every crackle, every layer, every echo carries the weight of a ritual act, as if music still holds its spiritual, liturgical, shamanic function.
This is an act of radical sound practice: to deconstruct in order to reconstruct the self. In an era of passive, predictive listening, SACROBOSCO urges us to get lost in the margins—in the B-sides, in the echo chambers of the self—where glitch becomes wound, and analog tape a relic of affection.
In this conversation, we descend into his vision.
Welcome. Time seems to lose its linearity and turn into something malleable: how much of the nostalgia in “Once” is personal, and how much is collective?
For those who, like me, lived through the technological transitions of the ’90s and 2000s, I believe it’s collective. But it's not exactly nostalgia—at least not in its usual sense. It’s more about an identity-based awareness, a biological connection to a materially technological world, which stands in contrast to today’s hyperconnected, privatized, exclusive digital landscape.Spending your teenage years making mixtapes is very different from consuming music via Spotify or YouTube. In one case, you’re a creator; in the other, just a user—or worse, a client.
Your artistic process seems to work through layering and resurfacing: in what way does sound manipulation become an archaeological—or even spiritual—act?
It’s spiritual in the sense that making music can become an act of alienation and ascension—like a prayer or a meditative gesture.
This multidimensionality fascinates me: something that transcends the current mainstream production logic, which is crushed by the need to be one-dimensional, instantly striking, unambiguous.
I think it reflects the mindset of today’s hyperconnected listener, who is losing the ability to think critically or to engage with content in depth.
In the dialogue between man and machine that flows through “Blackthrough,” is there room for algorithmic empathy? Or is the machine still something to be tamed?
Algorithms behind AI are not (at least not yet) autonomous entities. They’re tools built and constantly updated by human minds—and, like all human-made tools, they can be used for good or ill. These dual potentials have always coexisted.There can’t be empathy towards a mathematical function, but there can be creativity in its use.For example, in my last album I used Max8-based matrices to generate glitch noises rhythmically governed by the rest of my music. A small gesture—but it shows how powerful these tools can be if you take control.That said, the direction our world is heading in is deeply disturbing.
Your B-sides often feel like parallel paths—echo chambers of the main track. Are they lateral journeys or fragments of the same dream?
When working on an album, I always have a lot of material on my hands. I’m never quite sure what to include until I start building the actual tracklist. They’re all fragments of the same dream.I can only see their true purpose after the mixing phase—sometimes not even until after mastering.
Through walkmans, tapes, static and ghostly sounds, you seem to evoke an affective, fragile yet powerful technology. Is this a form of resistance against digital dematerialization?
In a way, yes. I think it’s the return of elements that are part of my identity as a listener and musician, rooted in a specific historical moment.
Just as someone born in England in the 1940s might have used music to express memories shaped by war and British pop culture, I’m channeling my own relationship with cassette tapes.
The walkman was both a refuge and a portal—it turned mundane experiences like a bus ride into moments of deep, interior connection through curated listening. It became a space of freedom.
The artwork for Apes + Tigers, by Ivan Pjevcevic, shows a tiger-monkey dissolving into color. How important is the visual aspect in completing the listening experience for you?
It's always been fundamental. The visual and the sonic are inseparable for me.
Some records wouldn’t have resonated as deeply without the impact of the cover art.
Not because the image was necessarily beautiful, but because it spoke to me. For instance, I wouldn’t call Nine Inch Nails’ The Downward Spiral cover conventionally beautiful—it’s just a photo of a corroded metal wire. But I still remember seeing it for the first time at my cousin’s house. He opened a drawer full of CDs looking for something to show me.That cover—rusted, ambiguous—imprinted itself in my memory. I didn’t hear the album until years later, but when I did, the visual context had already framed the music as something profound and haunting. And I’m glad I waited—because as a kid, I wouldn’t have understood its power.

The sonic memory you evoke is often fragmented, incomplete, demagnetized. Do you think modern listeners are capable of inhabiting the “undefined”?
I hope so. Even though the world wants to appear determined—impenetrable in its predictive logic—it’s actually full of openings, blank spaces, unfinished zones.We need to learn to inhabit and recognize them. But doing that requires experience, culture, knowledge—something you can only develop through direct contact with others, relationships, real encounters.All things the current world setup tries to pull us away from. My work reflects a sonic memory that I try to project into the present, precisely because I believe it creates friction, a necessary disturbance.
ITALIAN VERSION
Con SACROBOSCO, non ci troviamo davanti a un semplice artista, ma a un medium tra piani diversi dell’esperienza sensoriale: l’analogico e il digitale, l’umano e l’algoritmico, il ricordo e il glitch.

I suoi brani sembrano riemergere da un fondale psichico, come detriti sonori intrappolati tra i denti di una macchina del tempo rotta. Ma non è nostalgia: è resistenza emotiva. È un atto di affermazione identitaria in un mondo che si dissolve nella liquefazione algoritmica.
Con “Once”, SACROBOSCO interroga le geografie interiori della memoria, modellando il tempo come materia malleabile, con un linguaggio che è insieme sacro e tecnico, biologico e artificiale. Le sue composizioni non si consumano nell’ascolto immediato: vanno attraversate. Ogni crepitio, ogni strato, ogni eco sembra custodire un gesto sacrificale, come se la musica potesse ancora incarnare una funzione spirituale, liturgica, quasi sciamanica.
Il suo è un gesto artistico radicale: decostruire il suono per ricostruire la soggettività. In un’epoca di ascolto passivo e predittivo, SACROBOSCO ci chiede di perderci nei margini, nelle b-sides, nelle camere d’eco del sé. Là dove il glitch diventa ferita, e la cassetta analogica una reliquia affettiva.
In questa conversazione, ci addentriamo nei meandri della sua visione.
Benvenuto. Il tempo sembra perdere la sua linearità per diventare una materia da modellare: quanto è personale e quanto collettiva la nostalgia che abita “Once”?
Sicuramente per chi come me ha potuto vivere le trasformazioni tecnologiche tra gli anni ’90 e i 2000 credo possa essere collettiva. Ma non è propriamente “nostalgia”, per lo meno non nel suo significato più comune. È qualcosa che ha più a che fare con una presa di consapevolezza identitaria, del proprio legame biologico con un mondo tecnologicamente materiale, che si contrappone a quello digitale odierno, iperconnesso, privatizzato, esclusivo. Aver passato la propria adolescenza a creare mixtape è qualcosa di molto diverso rispetto alla fruizione di musica su Spotify o su Youtube. In un caso si è creatori di qualcosa, nell’altro solo utenti, o peggio, clienti.
La tua pratica artistica sembra procedere per stratificazioni e riemersioni sonore: in che modo la manipolazione del suono diventa un atto archeologico, o forse addirittura spirituale?
È spirituale nella misura in cui fare musica può essere considerato un atto di alienazione e ascesi, come possono esserlo una preghiera o un atto meditativo.
Mi sta interessando molto questa multidimensionalità, qualcosa che può trascendere le produzioni mainstream del momento, schiacciate invece dall’esigenza di essere monodimensionali, di colpire nell’immediato e in maniera univoca.
Credo sia il riflesso della mentalità dell’ascoltatore tipico nell’era dell’iperconnessione, che sta perdendo la capacità critica di elaborare i contenuti o di guardare al fuori di essi.
Nel dialogo tra uomo e macchina che abita “Blackthrough”, c’è spazio per un’empatia algoritmica? Oppure la macchina è ancora, in fondo, un’entità da domare?
Gli algoritmi alla base dell’AI non sono (almeno per ora) entità autonome. Sono strumenti progettati e costantemente modificati da menti umane, e come ogni strumento al servizio dell’uomo possono essere utilizzati in maniera utile o meno, a vantaggio o a danno dell’umanità. Entrambe le modalità coesistono storicamente da sempre. Non può esserci empatia nei confronti di una funzione matematica, ma può esserci la capacità di sfruttarla in maniera senza dubbio creativa. Ho utilizzato nel mio ultimo disco, ad esempio, delle matrici sviluppate su Max8 per ottenere dei rumori glitch “governati” ritmicamente in funzione della mia musica. È un piccolissimo esempio, si possono fare cose davvero incredibili prendendone il controllo. Tuttavia il nostro presente sembra indicarci una direzione globale connotata da aspetti molto inquietanti.
Le tue B-sides sembrano spesso costituire percorsi paralleli, come camere d’eco del brano principale. Sono viaggi laterali o frammenti dello stesso sogno?
Quando lavoro ad un disco ho sempre molto materiale tra le mani, di cui non so esattamente cosa includere e cosa no almeno fino a quando non inizio effettivamente a costruire una tracklist. Sono tutti frammenti dello stesso sogno, di cui riesco ad avere un’idea chiara sul loro utilizzo solo dopo la fase di mix, a volte addirittura dopo quella di mastering.
Tra walkman, cassette, crepitii e suoni fantasma, sembri evocare una tecnologia affettiva, fragile ma potentissima. È una forma di resistenza alla smaterializzazione digitale?
In un certo senso si, credo si tratti del ritorno di elementi che sono parte della mia identità di ascoltatore e musicista, collocato in un preciso periodo storico al quale rispondo in termini di linguaggio.
Esattamente come chi era nato in Inghilterra negli anni ’40 si è ritrovato a raffigurare attraverso la musica immagini legate ad un’infanzia permeata dalle inquietudini della guerra fuse con la cultura educativa britannica, permeata di Carroll e di atmosfere da Luna Park, io ho rievocato il mio rapporto con i nastri delle musicassette.
L’uso del walkman ha svolto sia la funzione di rifugio che quella di mezzo per ampliare esperienze altrimenti comuni, e magari noiose, come un viaggio in bus o in treno, dove poter ascoltare una selezione appositamente registrata e staccare la spina per connettermi a qualcos’altro di libero e interiore.
L’artwork di Apes + Tigers, firmato da Ivan Pjevcevic, mostra una tigre-scimmia che si dissolve nel colore: quanto conta per te l’aspetto visivo nel completare l’esperienza d’ascolto?
E’ stata sempre fondamentale, direi che le due cose hanno avuto per me un legame importantissimo.
Alcuni dischi non mi sarebbero piaciuti allo stesso modo se non mi fossi prima di tutto perso nella copertina.
Non vuol dire che deve essere oggettivamente bella o accattivante, semplicemente deve arrivarti, parlarti. Ad esempio, non giudicherei la copertina di The Downward Spiral dei Nine Inch Nails una copertina oggettivamente bella. Non verrebbe a tutti in mente l’idea di fotografare una corda di metallo arrugginita e di renderla l’artwork di un album, ma ricordo perfettamente la prima volta in cui la vidi, a casa di un mio cugino musicista, più grande di me, che aprì un cassetto pieno di cd alla ricerca di qualcosa da farmi ascoltare. L’immagine di quell’oggetto indefinito e corroso dal tempo mi si stampò per sempre nel cervello e condizionò profondamente l’ascolto dell’album, che fortunatamente avvenne solo dopo molti anni, perché non credo avrei compreso la potenza di quelle tracce all’epoca. Ero troppo piccolo.
La memoria sonora che evochi è spesso frammentaria, incompleta, smagnetizzata: credi che il nostro ascolto moderno sia capace di abitare il “non determinato”?
Me lo auguro, anche perché nonostante il mondo voglia apparirci come determinato, anzi quasi inscalfibile nella sua predeterminazione, è in realtà pieno di aperture, spazi vuoti, incompleti, che occorre in qualche modo riuscire a fare propri e riconoscere in quanto tali. Questo comporta una certa preparazione, una cultura, un know-how che si raggiungono solo attraverso l’esperienza concreta, le relazioni, l’incontro con l’altro, tutti aspetti da cui il setting del mondo attuale cerca di distoglierci. La mia è il riflesso di una memoria sonora che intendo proiettare nel panorama attuale, perché sento che questo produce un attrito, una reazione.



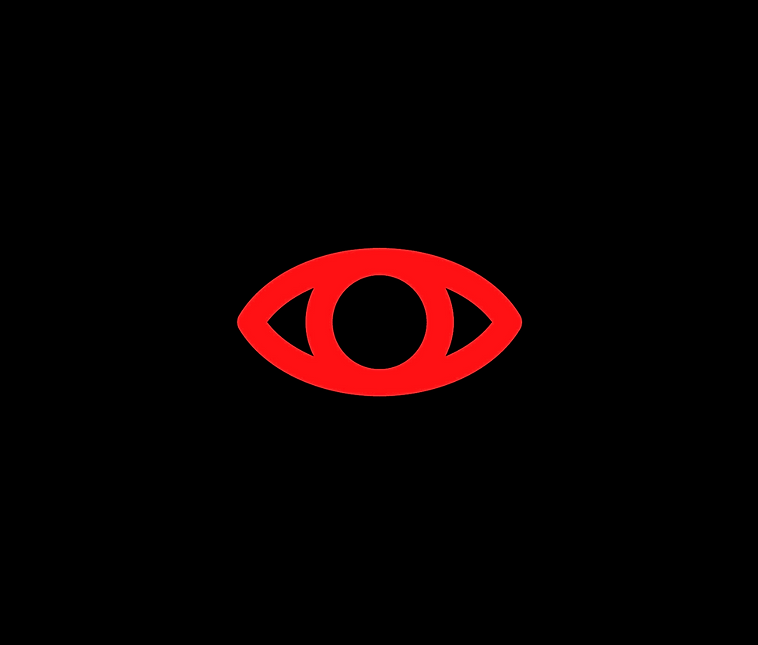.png)
Commenti